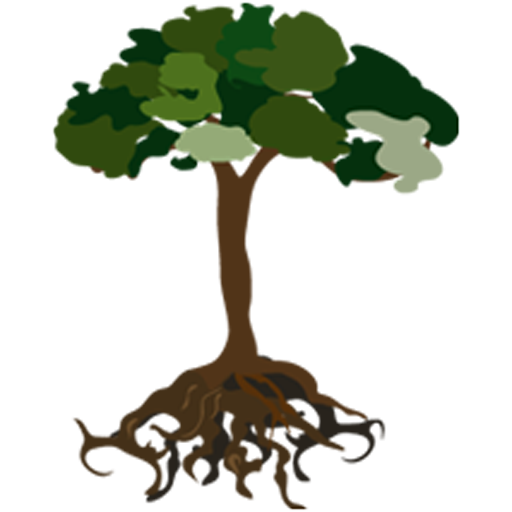Cari fratelli e sorelle,
Ci ritroviamo in questa chiesa parrocchiale per accompagnare con la preghiera l’ingresso nella vita eterna del nostro sacerdote di Cristo don Antonio Uras. La sua vita è racchiusa tra la nascita nel giorno della vigilia di Natale dell’anno 1924, l’ordinazione presbiterale nel giorno della festa di San Domenico, fondatore dell’Ordine dei Predicatori, l’8 agosto del 1948, la morte, avvenuta il 17 novembre, nel giorno della memoria di Santa Elisabetta d’Ungheria, la santa dei poveri. Queste date sono apparentemente insignificanti, ma possono rivelarsi come un simbolo d’una esistenza consacrata dalla presenza del Figlio di Dio sulla terra, dalla predicazione del Vangelo nel mondo, dall’opzione preferenziale per i poveri. Personalmente, ho sentito solo parlare del lungo ministero parrocchiale di don Antonio a S. Sebastiano, preceduto da un breve periodo di tre anni di viceparroco in Cattedrale. Io l’ho conosciuto quando era già ritirato e infermo, e posso ricordarlo nella comunione della preghiera che, insieme, facevamo per la parrocchia, la Diocesi, il Seminario. Chi invece, come voi, l’ha conosciuto nella pienezza del suo ministero, lo ricorda certamente con ammirazione e gratitudine per il servizio di genuina testimonianza cristiana, che egli ha reso alla Chiesa Arborense. Se una sintesi si può fare del suo ministero è quella d’un sacerdote che ha cercato di portare Dio agli uomini più che portare gli uomini a Dio. In qualche modo, è stato un precursore dello stile di papa Francesco, che ha una grande passione per l’umanità. Papa Francesco antepone l’uomo alla dottrina, la persona alla legge. Vuole portare Dio agli uomini non con l’indottrinamento, ma con una carezza, ossia con il linguaggio del cuore, che tutti possono capire. Gesù è stato la tenerezza di Dio per gli sconfitti dell’umanità. Sapeva bene che anche coloro che erano abbandonati andavano accarezzati e in questo modo dava loro la possibilità di rinascere.
A noi, chiamati dall’Apostolo “figli della luce e figli del giorno, non appartenenti alla notte né alle tenebre”, la scomparsa di don Antonio, come ogni scomparsa d’una persona cara, insegna che la morte si vive e agisce su i vivi. Ernest Hemingway in Addio alle armi ha scritto: “Ogni morte di uomo mi diminuisce, perché io partecipo dell’umanità: e così non mandare mai a chiedere per chi suona una campana, essa suona anche per te.” E i Medioevali dicevano in media morte vivi sumus, in media vita mortui sumus, nel mezzo della morte viviamo, nel mezzo della vita moriamo. In ultima analisi, la morte fa parte dell’esistenza, e, perciò, non può essere rimossa, descrivendola ai bambini con le parole ingannevoli delle favole, o eliminandola dalla storia dell’uomo, con le parole altrettanto ingannevoli della religione della tecnica. L’uomo è per la morte, la sua patria è nei cieli, il suo stile è la vigilanza. Ce lo ricorda la pagina del Vangelo di oggi.
La parabola dei talenti, infatti, non è un’esaltazione dell’efficienza economica o finanziaria, non è un inno alla meritocrazia. La sua prospettiva è un invito alla vigilanza. Essa fa parte del Discorso della Nuova Legge (Mt 24,1 a 25,46) e si colloca tra la parabola delle dieci vergini (Mt 25,1-13) e la parabola del giudizio finale (Mt 25,31-46). Queste tre parabole chiariscono il concetto relativo al tempo dell’avvento del Regno. La parabola delle dieci vergini insiste sulla vigilanza: il Regno di Dio può giungere da un momento all’altro. La parabola dei talenti orienta sulla crescita del Regno: il Regno cresce quando usiamo i doni ricevuti per servire. La parabola del giudizio finale insegna come prendere possesso del Regno: il Regno è accolto, quando accogliamo i piccoli.
Inoltre, la parabola ci mette in guardia sull’idea che noi ci facciamo di Dio. Il servo che ha conservato il talento, per esempio, confessa di avere un’immagine del Signore come di un padrone che fa paura, che chiede un rendiconto severo di ciò che è stato fatto e di ciò che è stato omesso, che agisce in modo arbitrario. Tra i contemporanei di Gesù, alcuni immaginavano Dio come un Giudice severo che trattava le persone secondo il merito conquistato con l’osservanza della legge. Ciò causava paura ed impediva alle persone di crescere. Impediva che aprissero uno spazio dentro di loro per accogliere la nuova esperienza di Dio che Gesù comunicava. Proprio, per aiutare ad avere un concetto giusto di Dio, Gesù racconta la storia di un uomo che, prima di mettersi in viaggio, distribuisce i suoi beni agli impiegati, dando cinque, due ed un talento, secondo la capacità di ognuno di loro. Un talento corrisponde a 34 chili d’oro, il che non è poco! In definitiva, tutti ricevono la stessa cosa, perché ognuno di loro riceve “secondo la sua capacità”. Chi ha la tazza grande riempie la tazza grande, chi ha la tazza piccola, riempie la tazza piccola.
Al ritorno del padrone dal suo viaggio, l’impiegato che ha ricevuto un talento dice: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; per paura andai a nascondere il tuo talento sotterra; ecco qui il tuo!” Dicendo questo, dimostra di avere un’idea sbagliata di Dio, criticata da Gesù. L’impiegato vede in Dio un padrone severo. Davanti a un Dio così, l’essere umano ha paura e si nasconde dietro l’osservanza esatta e meschina della legge. Pensa che agendo in questo modo eviterà il giudizio e che la severità del legislatore non lo castigherà. Così pensavano alcuni farisei. In realtà, una persona così non ha fiducia in Dio, bensì in se stesso e nell’osservanza della legge. E’ una persona rinchiusa in se stessa, lontana da Dio e non riesce a preoccuparsi degli altri. Diventa incapace di crescere come una persona libera. Questa immagine falsa di Dio isola l’essere umano, uccide la comunità, non fa vivere la gioia ed impoverisce la vita.
In definitiva, la parabola non vuole lodare chi produce e guadagna, ma indicare il modo in cui bisogna vivere la nostra relazione con Dio. I primi due impiegati si danno da fare perché il dono ricevuto frutti per Dio e per il Regno. Il terzo impiegato, invece, ha paura e, per questo, non fa nulla. Per la legge, lui agisce in modo politicamente corretto. Si mantiene nelle esigenze stabilite. Non perde nulla, ma nemmeno guadagna nulla. Per questo, perde perfino ciò che aveva. Vivere per il Regno di Dio vuol dire rischiare, uscire dalla propria terra, fidandosi solo della Parola di Dio. Il profeta Isaia esorta a lasciarci “stupire e affascinare dai pensieri e dalle vie di Dio, che non sono i nostri pensieri e le nostre vie”. Papa Francesco ci dice: “meglio una Chiesa ferita ma presente sulla strada, che una Chiesa malata perché chiusa in sé stessa”. “I cristiani sono gente di primavera più che di autunno”.
Cari fratelli e sorelle,
preghiamo perché don Antonio, dall’alto dei cieli, interceda presso il Padre per il nostro presbiterio, la nostra comunità aborense, affinché abbiamo il coraggio di “osare il Vangelo”, di essere cristiani credibili perché cittadini onesti, di credere in Dio senza rinunciare alla fede nell’uomo.
La sua memoria sia benedizione!
Amen.