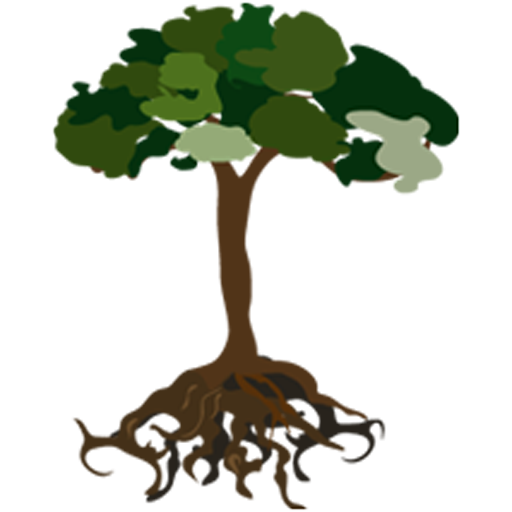Riflessione iniziale dell’ arcivescovo Roberto per l’incontro di condivisione e riflessione con il presbiterio Arborense.
Carissimi tutti, ci ritroviamo dopo quattro mesi durante i quali siamo stati coinvolti e forse travolti da una situazione inattesa, che possiamo ben dire ci ha trovati impreparati e che purtroppo – come ci informa la cronaca – non è ancora conclusa. Dobbiamo ancora una volta riconoscere che questi mesi hanno segnato, anche in modo drammatico la nostra vita personale e quella delle nostre comunità cristiane.
In Sardegna non abbiamo avuti i numeri di contagi e di morti di altre regioni, ma nonostante ciò il clima di incertezza e paura è stato vissuto anche qui. Il nostro incontro di oggi nasce dal desiderio di ritrovarci come presbiterio per poter almeno condividere insieme qualche cosa di quanto abbiamo vissuto in questo tempo di pandemia, e riflettere su quanto ci aspetta sia nel periodo estivo sia alla ripresa delle attività pastorali in autunno.
Sappiamo bene che non si può né si deve pensare che “tutto ritorni come prima” ma che dobbiamo imparare a convivere sia con il virus del Covid19, sia portare a maturazione esperienze e buone prassi che abbiamo sperimentato; come pure occorre avere onestamente uno sguardo critico su ciò che si è rivelato non utile o transitorio. Dobbiamo dirci che sino ad oggi esisteva nel nostro immaginario “occidentale” il Mito della invulnerabilità.
Quando tutto è iniziato, in Cina, così lontano, abbiamo pensato che a noi non sarebbe accaduto niente, così come capita di pensarlo in occasione di catastrofi e situazioni lontane dal nostro mondo. Prima pensavamo che la fragilità e i limiti fossero per gli altri, per quelli lontani, per i paesi non sviluppati, invece ci siamo dovuti accorgere che ha toccato anche noi. La natura ci ha fatto sapere che è più forte e imprevedibile. Abbiamo pensato a lungo: non può succedere a noi, non così vicino, non così presto!
Ci siamo cullati nell’idea che con tutti i progressi della scienza si poteva affrontare qualsiasi problema. Inoltre, chi di noi si aggira attorno ai 60 anni è cresciuto in un tempo di pace, di tranquillità, di sicurezza e fiducia nel progresso tecnico. Eravamo dunque fiduciosi, senza avvertire particolari pericoli. Ma questo virus invisibile ha messo tutto in discussione, facendoci toccare con mano la nostra fragilità.
Abbiamo vissuto una situazione insolita per l’umanità, che non ha precedenti nella storia per velocità di diffusione nei vari continenti. Le epidemie del passato erano circoscritte a un paio di nazioni e poi non si sapeva tutto in tempo reale, come oggi accade, di quello che succedeva dall’altra parte del mondo.
La Chiesa italiana (e non solo) è stata tra le prime ad essere interessata dai provvedimenti di contenimento, con la sospensione delle celebrazioni e l’interruzione della vita comunitaria. Di fronte alle decisioni della autorità ecclesiastica c’è chi (anche tra noi) ne ha fatto un rimprovero per una troppo veloce e arrendevole obbedienza alle indicazioni del Governo. Altri hanno risposto con una creatività, anche liturgica, non sempre adeguata anzi a volte proprio maldestra. Altri hanno acceso la polemica nei confronti della latitanza della Chiesa, vedendo in quello che è successo la disfatta della rilevanza sociale della religione.
Di fatto siamo stati tutti un po’ disorientati. Per qualche tempo, anche come vescovi e presbiteri non si sapeva cosa fare, quali percorsi prendere. Senza la comunità, senza la “corporeità” e la presenza della comunità ci siamo sentiti persi. Quando ci sono altre tragedie nella società, come Chiesa siamo abituati ad occuparci dei corpi (nei terremoti, carestie, alluvioni, povertà, fame).
Con la pandemia invece la Chiesa ha dovuto fare un passo indietro per far posto alla scienza, ai medici, ai virologi.
Privata della prossimità, è sembrato che la Chiesa rimanesse senza parola. Tutti ci siamo chiesti: cosa possiamo dire come Chiesa, quale sarà la parola all’altezza della situazione? Ci siamo resi conto che sarebbe stato compito della Chiesa dire una parola per le persone smarrite. Forse la nostra Chiesa italiana non ha pronunciato una parola autorevole, orientatrice, profonda, illuminante. Ci siamo accorti come le “parole religiose” possono essere consumate dall’uso e abuso.
Dato che la liturgia veniva limitata, e anche la carità ha avuto le sue difficoltà, ci si aspettava una parola capace di orientare. Lo ha fatto Papa Francesco con i suoi gesti e le sue parole: la preghiera in una piazza San Pietro vuota, sotto la pioggia con l’immagine del Crocifisso e l’Icona della Madre di Dio.
Bisogna però anche dire che la Chiesa non è stata assente: ha mostrato il suo volto più vero in una vitalità meno alla ribalta. Molti preti si sono dati da fare per mostrare prossimità alle persone. Chi ha favorito la preghiera in famiglia, o una riflessione sulla Parola.
La nostra realtà diocesana, come pure quella della diocesi di Ales-Terralba ha mostrato anche risposte importanti da parte dei preti, tanto da poter dire che la Chiesa non è stata assente, seppure vi è stata diversità di “presenza”. Ad esempio la Caritas delle due diocesi ha funzionato, con l’importante contributo dei volontari. Si è data da fare per aiutare, distribuire viveri, sollevare situazioni drammatiche e ancora lo fa. Si sono levate anche voci per quello che qualcuno ha chiamato il “lutto eucaristico”, cioè la difficoltà a poter celebrare l’eucaristia con la comunità.
Ma credo che questa sofferenza ha talvolta originato, o doveva originare, una valorizzazione della Scrittura, ovvero della Parola di Dio come mensa spirituale. È il Concilio che, rifacendosi alla tradizione de Padri, parla delle due mense “quella eucaristica e quella della Parola di Dio”. Ancora una volta, diversi presbiteri si sono dati da fare per aiutare le comunità anche a vivere in famiglia i riti pasquali; si è riparlato di sacerdozio comune che nasce dalla dignità battesimale.
Abbiamo dovuto fare i conti con il “digitale”. Eravamo consapevoli che il digitale ha cambiato il mondo del lavoro, il tempo libero, le relazioni. In questa situazione, con una certa “forza e forse violenza” ha cambiato e cambierà anche la nostra pastorale. Come ci testimoniano le inchieste statistiche, i numeri dei contatti on line di messe o catechesi, sono stati molto più alti degli abituali frequentatori delle nostre chiese. Tanta gente nuova, tanti ritorni.
Questi mezzi, in sostanza, si sono rivelati un grande strumento di condivisione, che ci ha rivelato un mondo bisognoso di Parola molto più vasto dei nostri confini. Dobbiamo adesso essere saggi. Non significa che abbiamo trovato le soluzioni magiche ai problemi della pastorale o della partecipazione della gente. Non sarà il digitale a risolvere i problemi di una fede non approfondita o immatura. Però possiamo chiederci come riproporlo nel contesto degli altri modi di comunicare il vangelo, dell’incontro, della condivisione.
Cosa ci possiamo aspettare per il futuro? Non sono del tutto certo che questa esperienza porterà cambiamenti duraturi, mi riferisco alla vita cristiana, ma si può pensare questo anche degli altri aspetti. I cambi hanno bisogno di tempo, motivazione profonda, e percezione di una strada che si apre. In fondo i tempi non sono stati così lunghi, le motivazioni non troppo profonde e la strada che si apre non molto chiara.
Mi ha colpito una frase del Card. Zuppi, arcivescovo di Bologna: «vedo tre pericoli, tre tentazioni di fronte a ciò che abbiamo vissuto: Quelle di cadere nel vittimismo, nel narcisismo, e nel pessimismo. Sono tre tentazioni che hanno in comune la ricerca ostinata di una sicurezza a buon prezzo. E sono tre tentazioni che si nutrono una dell’altra. Il vittimismo che è espressione di un fatalismo pagano. Il narcisismo, che suppone l’esclusività della nostra sofferenza. Il pessimismo che ci fa scordare che cinquanta metri sotto la croce c’è una tomba vuota. Alcuni certo, nel modo di comportarsi, ma credo che nel modo di percepirsi e anche nel modo di vivere la propria fede, sia come presbiteri che cristiani laici saremo tentati di ritornare al “prima”». Il Papa ha detto che “non possiamo permetterci di sprecare questa crisi”. Significa che dobbiamo leggerla, non solo nei suoi aspetti sociali, ma antropologici, spirituali, cristiani. L’attenzione ai deboli, agli anziani, il problema del rispetto degli altri, la consapevolezza della fragilità, il fatto che tanti “riti” (processioni, feste, ecc… ) alla fine possono anche essere cambiati, ridotti, divenire più sobri, deve farci pensare.
Quali atteggiamenti necessari per poterci rimettere in cammino? Come Chiesa arborense, come presbiterio, come singoli e comunità? Innanzi con tutto un tempo di silenzio e di riflessione. Un silenzio che prepara a dire parole di speranza. Credo non sia inutile aiutare le comunità a riflettere su quanto si è vissuto e ancora si sta vivendo, e a chiedersi: “cosa ci ha insegnato per la nostra vita cristiana?”. Forse dobbiamo chiedere un po’ di silenzio ai social.
Nell’omelia della messa crismale, ho parlato della necessità di riprendere un “galateo” nell’uso dei social, improntato ai codici di rispetto, benevolenza, verità. Lo ripeto: siamo chiamati a far crescere la comunità al rispetto, alla benevolenza, alla verità, ma prima di tutto dobbiamo chiederlo a noi stessi. Non dobbiamo vedere nelle persone degli avversari, anche se essi non condividono la fede, oppure sono saltuari o distratti o superficiali o altro. Dobbiamo, con uno sguardo di benevolenza, trovare il modo di entrare in dialogo. Non è detto che questo li porti in Chiesa, ma almeno possiamo ritrovarci in una “umanità condivisa”.
Dobbiamo, dopo un silenzio meditativo, dare alla comunità una parola di speranza, una lettura della situazione, una prospettiva anche di altro cammino.
Come presbiteri dobbiamo riprendere la lettura dell’esperienza nel contesto della preghiera personale. Non possiamo accontentarci di risposte “ragionevoli”, ma cercare significati e risposte che nascono dalla fede e dal rapporto personale con Gesù Cristo. Altrimenti rischiamo di fare solo un esercizio di buon senso, di lettura intellettuale, escludendo la luce che ci proviene dall’essere Chiesa.
Nel nostro primo incontro a ottobre 2019 qualcuno di voi nelle condivisioni aveva detto che vi era l’impellente necessità di riprendere la spiritualità presbiterale, la quale deve avere al centro la persona di Gesù Cristo. Niente di nuovo, si dirà, ma forse possiamo vedere un pericolo che sempre incombe per noi che “frequentiamo quotidianamente” le cose di Dio. Farne routine, abitudine, lavoro, piuttosto che scelta di vita. Riprendere il dialogo personale con il Signore e nutrirci della Sua Parola e della Eucaristia è il fondamento di tutto.
Diamoci adesso un tempo di condivisione e ascolto su ciò che si è vissuto, con le sue luci ed ombre. Credo sia importante anche qualche suggerimento di buona prassi che ci possa aiutare per il futuro.
+ Roberto, arcivescovo