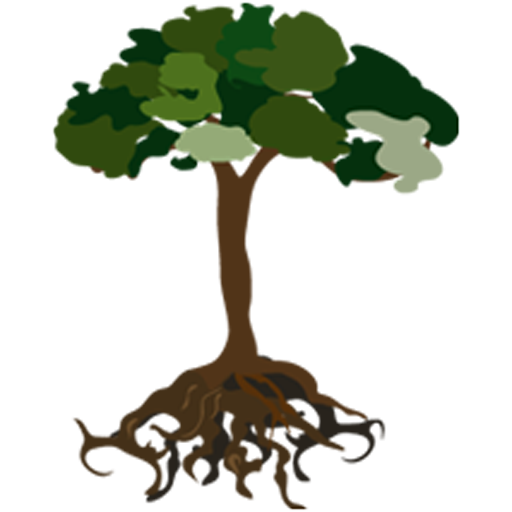Dignità, uguaglianza e fratellanza sono, tra i diritti umani, quelli riconosciuti all’uomo semplicemente per la sua appartenenza al genere umano. In egual misura questo riguarda chi vive la condizione di detenuto. Al di là degli errori commessi, per i carcerati i diritti non possono essere disattesi e, in questo periodo emotivamente pesante in cui il distanziamento è un’esigenza imprescindibile, lo scambio affettivo per loro ha un peso ancora più importante.
Don Alessandro Floris, rettore del Seminario di Oristano, da pochi mesi ha la cura spirituale dei detenuti della Casa di reclusione di Massama. Il sacerdote parla dei suoi momenti di vita condivisa con i detenuti all’interno della struttura. Mi ritrovo con loro almeno tre volte a settimana; celebro la messa il sabato e la domenica mattina e commentando la parola di Dio, cerco di offrire loro spunti e messaggi di riflessione, racconta Don Alessandro. Sono con loro da poco tempo, quindi sto entrando con garbo e delicatezza nella loro dimensione esistenziale. Sento che loro piano piano stanno aprendo i loro cuori e con fiducia cercano di comunicare i loro stati d’animo e le loro paure. Mi affidano i loro sfoghi ed esprimono tutte le difficoltà del momento, talvolta anche proponendo ciò che si potrebbe migliorare all’interno della struttura.
Don Alessandro, a che cosa serve la pena?
Noi siamo qui perché abbiamo sbagliato, mi dicono spesso i ragazzi che vado a trovare in carcere. Ma è chiaro che per me la pena deve essere il tempo per riflettere, il momento in cui l’errore commesso diventa il mezzo per affrontare se stessi e lavorare per crescere umanamente. Questo è un passaggio importante nei detenuti perché non sono rari i casi in cui chi esce dopo anni di carcere, ricada ancora in qualche errore. Credo che sia necessaria la presenza di figure che li accompagnino in questo percorso dove devono prepararsi a ciò che saranno una volta rientrati nella comunità esterna. Psicologi, psichiatri, medici, tutto il personale ha un ruolo determinante nel preparare i detenuti a ristabilire quelle relazioni affettive che nel periodo di carcerazione sono venute a mancare. Sono persone fragili che hanno bisogno di un sostegno anche dopo.
Il carcere è il luogo in cui il vissuto di ogni detenuto, interagisce con quello degli altri e con l’istituzione penitenziaria; non ci si può nascondere, si intersecano abitudini, credenze, linguaggi e sistemi di vita. La pandemia non ha risparmiato nulla e nessuno, e anche il sistema carcerario ha subito profondi mutamenti e continua con rigore ad affrontare l’emergenza sanitaria, osservando le disposizioni per frenare l’insorgere del virus. La sospensione delle visite di familiari e l’interruzione di attività esterne sono tra le disposizioni più forti e necessarie che portano i detenuti a vivere maggiormente la condizione di solitudine e il senso di abbandono.
Come vivono i detenuti questi tempi così difficili in cui il distanziamento, per loro quasi una consuetudine, è un’esigenza imprescindibile?
L’emergenza sanitaria ha accentuato l’isolamento; fisicamente non possono incontrare i familiari se non in situazioni molto gravi. Questa è una grande mancanza affettiva e relazionale che talvolta determina dei malesseri, delle incomprensioni che poi sfociano in atteggiamenti carichi di tensione emotiva. Il contatto umano è essenziale per tutti i detenuti, per i pochi sardi che sono presenti e in egual misura per gli altri. La tecnologia è stata di grande aiuto in questi lunghi mesi ed è stata indispensabile per abbattere le distanze. Videochiamate, ma anche semplici chiamate vocali hanno permesso ai detenuti un contatto costante con la famiglia. Questo tipo di comunicazione diretta li ha fatti sentire meno soli e allo stesso tempo più presenti nelle vite dei familiari lontani.
Vivere l’Avvento nelle carceri in questo tempo di distanziamento: tutto è rallentato e ostacolato dall’emergenza Covid-19, ma lei è vicino anche fisicamente ai detenuti. In che modo?
In questi giorni di Avvento, con l’aiuto di altri sacerdoti ci siamo dedicati alle confessioni. Il Sacramento ci dà poi la possibilità di aprire al dialogo, un confronto tra noi e loro che con rispettosa e conquistata confidenza aprono cuore e animo. I detenuti vengono in cappella per la Santa messa. Io invece li raggiungo reparti e mi fermo per un po’. Mi piace confrontarmi con loro, non posso farlo per ciascuno, sono davvero tanti, ma è ugualmente un momento atteso, di confronto e di scambio relazionale ed emotivo. Pur essendoci da poco tempo ho la sensazione che si stia creando un clima di fiducia. Il mio compito come uomo e come sacerdote è prima di tutto quello di ascoltarli perché nel momento in cui nasce la relazione nasce lo scambio e io sono lì per dare loro il conforto per il presente, ma anche per infondere speranza: sì hanno sbagliato, stanno pagando, ma una volta fuori devono poter voltare pagina.
A cura di Laura Mastinu
Pubblicato su L’Arborense 45/2020