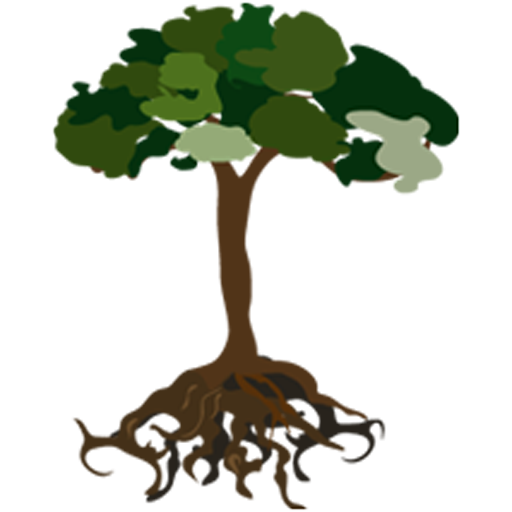Che la pandemia sia stata un peso opprimente in tutti gli strati sociali e in tutte le attività umane, è ormai un dato assodato. Per circa tre mesi le comunità parrocchiali non si sono potute riunire; le celebrazioni che, almeno negli ultimi 50 anni, caratterizzavano la Quaresima, la Pasqua e la Pentecoste non si sono potute tenere; i parroci hanno, di solito, celebrato da soli e con qualche assistente.
Alcuni parroci hanno voluto sperimentare nuovi mezzi di comunicazione e anche di celebrazione: hanno voluto fare di necessità virtù, come dichiara la sapienza popolare. Il tentativo in sé non solo è moralmente ed ecclesialmente buono e giusto ma, non avendo avuto altre indicazioni o direttive dai nostri vescovi, è stata anche l’unica cosa realizzabile. Ed ecco la fantasia e l’inventiva di molti operatori pastorali, farsi avanti in modo da poter offrire un sussidio per la preghiera in famiglia o per la spiritualità personale con le dirette via radio, Facebook, YouTube o tv.
Abbiamo celebrato i misteri della nostra fede in un modo assolutamente originale e nuovo. Ci sono stati alcuni teologi che si sono permessi, un po’ maldestramente, di affermare che tutto è secondario anche la liturgia, che i sacramenti non sarebbero indispensabili perché Dio per salvare il suo popolo non è vincolato da riti e liturgie (scoprendo così l’acqua calda… ma dimenticando che la Liturgia è fonte e culmine della vita della Chiesa).
Con la ripresa delle celebrazioni comunitarie, parroci e assemblee hanno dovuto cercare di far fronte alle nuove regole imposte dai protocolli governativi, controfirmate dalla CEI e alle quali bisogna adeguarsi. A causa degli ambienti spesso troppo piccoli, i parroci si sono trovati difronte a nuovi dubbi: da un lato avrebbero potuto moltiplicare il numero delle celebrazioni per consentire a tutti di partecipare, d’altro lato si potevano prevedere celebrazioni all’aperto.
Entrambe le modalità hanno evidenziato non pochi problemi: il primo, moltiplicando le celebrazioni sarebbe diminuito il senso della comunità e della celebrazione unitaria; il secondo non è semplicissimo adeguare uno spazio destinato ad altro (sagrato o piazza, talvolta un giardino, un campetto o un vecchio cimitero) e farlo diventare all’improvviso, con la semplice posizionatura di 4 panche, 10 sedie e un tavolino, un luogo di celebrazione. Da questo punto di vista mi pare che il Covid-19 abbia creato nuove problematiche: infatti una cosa è celebrare in un ambiente chiesastico a ciò deputato, con una serie di luoghi e spazi destinati per loro natura (cfr. la dedicazione di una chiesa) ai vari riti, altra cosa è riprodurre all’aperto spazi liturgici assolutamente aleatori e provvisori.
Affrontare il tema relativo allo spazio liturgico significa considerare il sistema, assai complesso, della celebrazione nella sua interezza: lo spazio liturgico con i suoi fuochi (altare, ambone, sede del presidente, sedi dell’assemblea), poiché esso non è un elemento secondario bensì costitutivo dell’azione rituale. La celebrazione all’aperto è solo una delle possibilità previste dal Protocollo, e non credo personalmente che sia la migliore. Molti edifici di culto sono di dimensioni piccole, con problemi relativi alle uscite e agli ingressi tali da permettere la celebrazione solo a un numero esiguo di persone.
È inoltre cosa nota che, in questa situazione di emergenza, i luoghi chiusi, il numero delle persone e la ridotta possibilità di arieggiamento, siano fonte di elevato rischio di contagio. Esiste un problema di forma della comunità: una chiesa coi i banchi mezzo vuoti, con un adesivo di divieto, con i fedeli tenuti a distanza, non riesce certo a dare forma al popolo di Dio chiamato a riunirsi insieme per celebrare il memoriale del Signore, però è il luogo che abbiamo offerto e consacrato a creare lo spazio per l’incontro con Dio e tra di noi, certo molto meglio di strade e piazze.
A cura di don Tonino Zedda, vicedirettore de L’Arborense.